Non cercare più, perché è qui.
Non cercare più, perché sei tu.
di Max Franti
Autore, collettore
Non cercare più, perché è qui.
Non cercare più, perché sei tu.
di Max Franti
No, non sono all’altezza.
Quasi mai.
Io devo rialzarmi:
con le mie mani, sollevarmi.
di Max Franti
Il tuo amore è un tormento
un bambino che chiede senza pace.
Ma che meraviglioso sentimento
quando si ferma, si guarda attorno e tace.
di Max Franti
Divisione del voi.
Moltiplicazione del noi.
Addizione del tu.
Sottrazione dell’io.
di Max Franti
Pendo dalle tue labbra.
Impiccato.
di Max Franti
Ascolta senza posa
oltre le tue mura:
il vento senza paura
carezza ogni cosa.
di Max Franti
Non so con quale sapere consumato
hai trovato la formula del mio nome.
Né so la lingua da cui hai ricavato
le parole per la mia definizione.
Né conosco lo strumento complicato
che ha fatto, delle mie stelle, una costellazione.
Forse è così semplice che non so pensarlo
così complicato che non so ridirlo.
Ma certo l’alchimia è quella di sempre:
nel buio ascolto di te stessa
è sorta la luna del mio nome.
di Max Franti
Stanno al suolo i germani reali,
è notte. Chiocciano
nel sonno e intanto sognano
il Messico e l’Honduras. Si china
il crescione su un fosso d’acqua irrigua
e i salici si abbassano,
sotto il peso dei corvi.
Campi di riso galleggiano sotto la luna.
E anche le foglie d’acero bagnate s’aggrappano
al parabrezza. Ti dico Maryann,
sono felice.
da Raymond Carver, Orientarsi con le stelle, minimum fax, p.81.
Fino a quando questo io, chiedevo a tutti,
che stanchezza
essere lo stesso essere, col nome e il numero,
con un silenzio nuovo
da orologio dimenticalo o da attrezzo
con l’impugnatura usata dalla mano.
La morte cade
sull’identità, riposano infine
non solo le vene e le ginocchia
ma anche questo nome nostro
maltrattato e sputato
come un povero soldato
mezzo morto tra il fango e la battaglia.
Ricordo quel giorno
in cui ho perso i miei tre primi nomi
e le parole che appartenevano
a chi? a me? o agli antenati?
È certo che non volli il conto d’altri
e pensai di inaugurarmi:
darmi il cognome, nominare me stesso
e crescere nel mio lievito soltanto.
Ma così tra la dolcezza e l’affanno
il corpo lungo, il raggio intermittente
della vita
è scivolato consumandomi i fianchi
e ho scoperto che ormai tutti mi chiamavano,
tutti assalivano il mio nome:
alcuni lo graffiavano
nel Senato con gli stuzzicadenti,
altri bucherellavano la mia figura
come se fossi fatto di formaggio:
non mi è servita la mia maschera notturna,
la vocazione silvestre.
E mi sono sentito nudo
dopo tante decorazioni,
pronto a tornare da dove sono venuto,
all’umidità del sottosuolo.
Non c’è pietà per l’uomo tra gli uomini,
seppure nascondi gli occhi sarai visto,
udito anche se non parli,
non sarai invisibile,
non resterai intatto:
i tuoi nomi ti denunciano
e ti mordono i denti del cammino.
di Pablo Neruda, Geografia Infruttuosa, Marietti, 1992, p. 93.
Questo amore
Questo amore malato, denutrito, fatto di parole smozzicate.
Questo amore usato, digerito, buttato in pasto al popolo ignorante
come fosse una cosa interessante.
Questo amore corrotto dalla noia,
dei grandi amatori della storia,
masticato da cento letterati,
vomitato da principi e prelati.
Questo amore che accoglie, che perdona,
fatto per gente dalla bocca buona.
E’ un amore di fradicia letizia, che assolve tutto, pure l’ingiustizia.
Questo amore sciancato, deficiente,
sbattuto sulla faccia della gente come l’osso al cane disperato.
Questo amore scarnito, rosicchiato, coi suoi stracci di corpo denudato.
Questo amore di cui si parla tanto, celebrato con tutte le grancasse.
Questo amore è disceso tra le masse, elargito per grazia del potere
perché tutti ne possano godere.
E’ un amore deforme, malandato,
generato dal vecchio capitale
tra le cosce del mondo occidentale.
Per questo amore è meglio non cantare
perché non c’è una musica che tenga.
E questa mia canzone sgangherata non sa nemmeno cosa la sostenga.
Avesse almeno la grazia più sgolata di una puttana sola, disperata,
piuttosto che la facile malia, il fascino penoso
di nostra borghesia.
Ma quell’amore che era una certezza si è assopito con l’ultima carezza.
Ha ripiegato pian piano le sue foglie rinunciando per ora alle sue voglie.
L’anima mia per questo si è ammalata non sogna più e resta addormentata.
Prima che il vuoto tutti ci divori che venga, venga presto il tempo in cui ci si innamori.
Prima che il vuoto tutti ci divori che venga, venga presto il tempo in cui ci si innamori.
di Roberto Lerici.
Te
lasciarti essere te
tutta intera
Vedere
che tu sei tu solo
se sei
tutto ciò che sei
la tenerezza
e la furia
quel che vuole sottrarsi
e quel che vuole aderire
Chi ama solo una metà
non ti ama a metà
ma per nulla
ti vuole ritagliare a misura
amputare
mutilare
Lasciarti essere te
è difficile o facile?
Non dipende da quanta
intenzione e saggezza
ma da quanto amore e quanta
aperta nostalgia di tutto
di tutto
quel che tu sei
Del calore
e del freddo
della bontà
e della protervia
della tua volontà
e irritazione
di ogni tuo gesto
della tua ritrosia
incostanza
costanza
Allora
questo
lasciarti essere te
non è forse
così difficile
di Erich Fried, E’quel che è. Poesie d’amore, di paura, di collera, Einaudi, Torino, 1983, p.60.
Pensa che si muore
e che prima di morire tutti hanno diritto
a un attimo di bene.
Ascolta con clemenza.
Guarda con ammirazione le volpi,
le poiane, il vento, il grano.
Impara a chinarti su un mendicante,
coltiva il tuo rigore e lotta
fino a rimanere senza fiato.
Non limitarti a galleggiare,
scendi verso il fondo
anche a rischio di annegare.
Sorridi di questa umanità
che si aggroviglia su se stessa.
Cedi la strada agli alberi.
Di Franco Arminio, Cedi la strada agli alberi, Chiarelettere, 2017, p.7.
La tua strada è una ferita
profonda
un solco arato dalla sofferenza.
Sorda, percorri la terra.
Vorrei che tu potessi vedere
la luce
oltre il buio
del tuo rimpianto.
di Max Franti
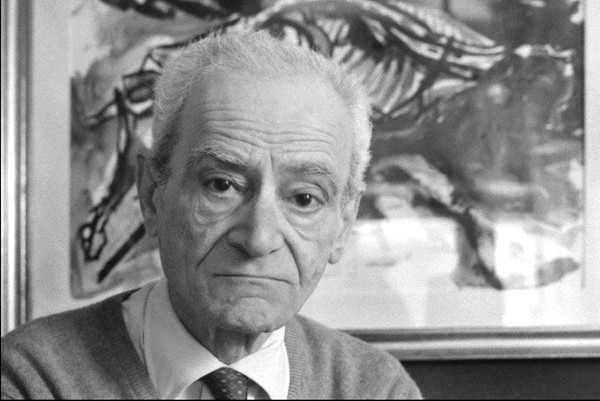
Devi perseverare
usare buona pazienza.
Ricordalo, se vuoi arrivare
al punto partenza.
Di Giorgio Caproni, Tutte le poesie, Garzanti, 1999, p. 524.
Ritorni, moltiplicata e continua
in ogni passo
in ogni volto o memoria.
Ritorni, enigma costante
come ultimo orizzonte
laddove non c’è più orizzonte
come ultimo ricordo dopo ogni ricordo
come ultimo ieri d’uno ieri più remoto.
Resti acqua oltre ogni schiuma e ti trasformi
sempre in te stessa.
Persisti oltre gli abbandoni.
Da lontano non si percepisce
il moto del tuo silenzio, che insiste.
Eppure ritorni
chiedendo quasi permesso
e continui a battere
oltre il cuore stesso.
di Max Franti
Dipinta, non vuota:
dipinta è la mia casa
del colore delle grandi
passioni e disgrazie
Ritornerà dal pianto
dove fu portata
con il suo tavolo deserto
con il suo letto rovinoso.
Fioriranno i baci
sopra i cuscini.
E intorno ai corpi
solleverà il lenzuolo
il suo intenso rampicante
notturno, profumato.
L’odio ammortisce
dietro la finestra.
Sarà artiglio soave.
Lasciatemi la speranza.
di Miguel Hernàndez
E’ assurdo
dice la ragione
E’ quel che è
dice l’amore
E’ infelicità
dice il calcolo
Non è altro che dolore
dice la paura
E’ vano
dice il giudizio
E’ quel che è
dice l’amore
E’ ridicolo
dice l’orgoglio
E’ avventato
dice la prudenza
E’ impossibile
dice l’esperienza
E’ quel che è
dice l’amore
da Erich Fried, E’quel che è. Poesie d’amore di paura di collera, Einaudi, Torino, 1983, p.79.
Ad un certo punto, nella piazza antistante la chiesa, ci sono bambini che giocano a calcio.
Le porte: una rientranza del pronao, due mucchi di vestiti gettati a terra.
Il numero dei partecipanti oscilla, impreciso, dispari, confuso.
Il fine del gioco sfugge, a volte. A volte è fare gol, ma altre è correre, urlare, inseguire.
Le squadre cambiano continuamente senza che la passione ne risenta.
Maschi e femmine giocano alla pari, nessuno impedisce a nessuno di partecipare.
Piccoli o meno grandi corrono e sudano come tutti gli altri.
(Una bambina corre dietro alla palla, sovrastata dai grandi: non urla, non parla.
Quando la partita si ferma si mette in disparte.
Quando la partita riprende, lei riprende a correre e inseguire.
Non tocca quasi mai la palla, ma non smette. Nessuno la esclude, nessuno le parla).
Tutti sono coinvolti e pronti ad andarsene.
Giocano con ardore: spinte, corse, cadute tutto viene metabolizzato rapidamente.
Nessuno rimprovera nessuno, quasi tutti urlano.
Ognuno gioca a modo suo, con quello che ha.
Il campo non è delimitato, tante cose o persone l’attraversano:
un bambino in monopattino
una signora con un bambino piccolo
un gruppo di turisti
una coppia innamorata
un cane.
Ma la partita non s’interrompe mai, chi passa viene inglobato.
I bambini si riorganizzano di fronte ad ogni cambiamento, senza problemi o patemi,
senza intoppi, senza lamenti. Hanno solo voglia di giocare.
Poi qualcuno sparisce, qualcuno si aggiunge.
La partita continua. Per sempre.
di Max Franti
Quando
la notte è a svanire
poco prima di primavera
e di rado
qualcuno passa
Su Parigi s’addensa
un oscuro colore
di pianto
In un canto
di ponte
contemplo
l’illimitato silenzio
di una ragazza
tenue
Le nostre
malattie
si fondono
E come portati via
si rimane.
Giuseppe Ungaretti, Tutte le poesie, Mondadori, p. 54.
Dei nostri incontri, ogni istante
festeggiavamo, come un’epifania,
soli, nell’universo tutto.
Tu,
più ardita e lieve d’un’ala d’uccello,
come una vertigine scendevi,
saltando gli scalini, e mi conducevi
oltre l’umido lillà, nel tuo regno,
al di là dello specchio.
Quando giunse la notte, venne
la grazia, le porte dell’iconostasi
si aprirono, e nell’oscurità in cui luceva,
lenta si chinava la tua nudità.
Nel destarmi: “Tu sia benedetta”,
dissi, sapendo quanto irriverente fosse
la mia benedizione: tu dormivi,
e il lillà si tendeva dal tavolo
a sfiorarti, con l’azzurro della galassia, le palpebre,
e sfiorate dall’azzurro, le palpebre
stavano quiete e la mano era calda.
Nel cristallo pulsavano i fiumi,
fumigavano i monti, rilucevano i mari,
mentre assopita sul trono
tenevi in mano la sfera,
e – Dio mio! – tu eri mia.
Ti destasti e
il quotidiano vocabolario degli umani
cambiò, e i discorsi si riempirono
di senso vero, e la parola “tu” svelò
il suo proprio significato: “zar”.
Alla luce tutto si trasfigurò, perfino
gli oggetti più semplici – il catino, la brocca e l’acqua,
stavano tra noi, come sentinelle.
Chissà dove fummo sospinti.
Città sorte per incantesimo,
si aprivano al nostro sguardo, come miraggi,
la menta si stendeva sotto i nostri piedi,
e gli uccelli c’eran compagni di strada,
e i pesci risalivan i fiumi,
e il cielo si schiudeva al nostro sguardo…
Mentre il destino ci inseguiva,
come un pazzo con il rasoio in mano.
di Arsenj Tarkowskij tratta dal film Lo specchio, di Andrej Tarkowski